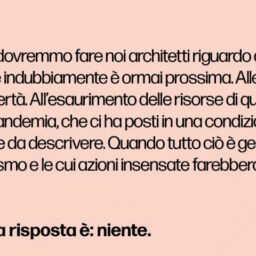Per capire quanto in realtà brevi siano 20 anni per caratterizzare in profondità culturale un’epoca, basti pensare alle stesse vite delle persone, di quella generazione che per quelli della mia furono “i nonni”, diciamo le persone nate fra l’ultimo decennio dell’800 e il primo del ‘900.
Queste persone hanno in genere vissuto pienamente due guerre mondiali, il fascismo, il dopoguerra, con la costituente e la nascita della repubblica, e infine il periodo del “boom” economico.
Evochiamo ad esempio alcuni nomi collegati con l’architettura: Curzio Malaparte (n. 1898), Giulio Carlo Argan (n. 1909), Bruno Munari (n. 1907), Giovanni Michelucci (n. 1891), Mario Ridolfi (n. 1904), Carlo Mollino (n. 1905) Luigi Moretti (n. 1906).[1] Per altri la vita si interruppe durante la seconda guerra: ad esempio Giuseppe Terragni (n. 1904), e Giuseppe Pagano (1896)
Fare il “test dell’anno di nascita” con i protagonisti del periodo può essere significativo per capire quanto la dimensione strettamente politica, sebbene importante nell’immediato, non sia mai talmente profonda da condizionare lo sviluppo dei temi culturali di un’epoca.
Si è ricordato in precedenza la riscoperta della architettura “vernacolare” e mediterranea da parte degli architetti razionalisti degli anni ‘30, particolarmente funzionale al regime per le sue politiche di potenziamento dei centri rurali e di infrastrutturazione dei territori coloniali.
Ma questo tema ebbe uno sviluppo rilevante – a prescindere – anche nel dopoguerra e a livello internazionale. Mi piace qui ricordare, come figura emblematica di ciò, Bernard Rudofsky (n. 1905), architetto austriaco attivo in Italia dal 1932 al 1938, periodo in cui lavorò come architetto con Luigi Cosenza (n.1905)[2] , e collaborò con Domus, allora diretta da Gio’ Ponti (n. 1891).
Come è noto, la ricerca di Rudofsky riguardo alla architettura vernacolare o “spontanea” culminò con la pubblicazione e la mostra al MoMA di NYC “Architecture Without Architecture”[3] senza dubbio rilevante per una certa architettura utopica e informale e organica dei ‘60.
Il tema del recupero di elementi costruttivi della architettura vernacolare fu centrale anche nel dopoguerra ad opera di architetti già affermati negli anni ‘30, come Mario Ridolfi, sotto l’etichetta del “neorealismo”. Il gioco di “etichettatura” di correnti artistiche in senso generico ha forse avuto la funzione di segnare una apparente discontinuità con il periodo del ventennio, che tuttavia oggi bisognerebbe ricalibrare nel segno della continuità. Questo vale anche per definizioni quali “realismo magico” che, seppure già presenti in anteguerra, risultavano meno caratterizzate da un’aura fascista rispetto a “metafisica”, ad esempio.
In questo senso è notevole che invece Ernesto N. Rogers (n. 1909) volle rimarcare il suo legame con la ricerca di Giuseppe Pagano ribattezzando la rivista di cui furono entrambe direttori Casabella-Continuità. Cosa possibile data la tragica fine di Pagano, catartica rispetto al suo passato di architetto al regime.[4]
Sotto questa luce, è pure da riconsiderare la circostanza che i giovani architetti di allora (generazione nata nel ventennio) cresciuti nell’ambito di quella “continuità”, politicamente a sinistra, utilizzarono un linguaggio che di fatto risulta totalmente riconducibile in continuità al Razionalismo anni ‘30: non solo Aldo Rossi e gli architetti della “Tendenza”, ma anche Gregotti e Aymonino, per citare solo alcuni fra i più influenti. Stessa cosa si può dire, in modo diverso, della scuola, risultata minoritaria, di Saverio Muratori (n.1910)
In questo senso, mi piace pensare che la “ritirata italiana dalla architettura moderna” dei giovani sotto l’ala di Ernesto Nathan Rogers, come venne definita da Reyner Banham[5], non fu una anomalia del “neoliberty” fine anni ‘50, ma invece il frutto di una peculiarità già in nuce nel Razionalismo italiano degli anni ‘20 e ‘30, così attento alle specificità locali e storiche, e, attraverso le successive elaborazioni di figure appunto come Ridolfi o lo stesso Rogers.
Vorrei spendere ancora qualche parola, riguardo a questi giovani di allora (nati proprio nel ventennio), nel considerare la posizione di Aldo Rossi, indubbiamente una figura di riferimento mondiale nella seconda metà del ‘900.
Aldo Rossi non fece mai alcun riferimento esplicito, dichiarato, di derivazione dalla architettura ed all’arte del ventennio, da cui evidentemente voleva smarcarsi in senso anti-provinciale[6].
Possiamo dire che prese il Razionalismo di allora e ne rintracciò le origini negli architetti “rivoluzionari” non solo secondo i fili individuati da Kaufmann[7], ma quasi ritrovando in archetipi, non soltanto classicisti, ma assoluti, senza tempo, il suo riferimento. Rossi dichiarava come suoi maestri e riferimenti moderni Loos, Mies, Tessenow. Esplicitava la sua simpatia per l’architettura dei paesi comunisti in tempo di guerra fredda.
Ma le sue opere, diversamente dalle parole, tradiscono innegabilmente una derivazione diretta dalla architettura italiana del ventennio. Direi anche proprio piacentiniana. Vorrei suggerire, di questo, un risvolto positivo, nel segno della “architettura della città”.
Quando Le Corbusier e il Ciam proponevano visioni di città massacrate dallo zoning, utopie automobilistiche di un visione quantitativa della città che purtroppo si è avverata nelle sue fallimentari e persistenti realizzazioni fino ai giorni nostri, in Italia, ad opera anche dei razionalisti, si è tentata una strada diversa, più basata sulla permanenza dei caratteri urbani tipici della città europea come venuta delineandosi nel corso della storia. Aldo Rossi, il suo modo di fare architettura, è all’interno di questa stessa storia.
Il fascismo era pur esso figlio della sua epoca. Fu una condizione transitoria, durata soltanto vent’anni, sotto il profilo culturale breve rispetto a quei fenomeni, a quei temi a cui comunemente viene associato.
Tuttavia questa relazione è ancora incidente rispetto alla nostra percezione delle cose.
Un Moloch che ci impedisce psicologicamente di rivendicare un valore e un rapporto con con i prodotti di quel periodo della società italiana, parte di quella internazionale.
È necessario oggi superare questo “complesso”, non per un inaccettabile recupero politico, ma, al contrario, per il riconoscimento della sua qualità culturale che comunque non era in funzione delle circostanze politiche, anche se con esse ha avuto un rapporto non indifferente.
LEGGI ANCHE GLI ALTRI ARTICOLI
NOI E L’ARCHITETTURA DEL VENTENNIO – PARTE III – ARCHITETTURE NEL MAGREB. UN CONFRONTO CON LA FRANCIA
NOI E L’ARCHITETTURA DEL VENTENNIO – PARTE II – DAVVERO È ESISTITO UNO “STILE FASCISTA” IN ARCHITETTURA?
NOI E L’ARCHITETTURA DEL VENTENNIO – PARTE I – INTRODUZIONE AL TEMA
[1] È da notare fu la “generazione degli ‘80”, individuata proprio così fra i musicisti (Respighi, Malipiero, Casella ecc.), fu quella di Mussolini, Piacentini, ecc, quella forse più coinvolta interamente nel ventennio.
[2] Rudofsky progettò con Luigi Cosenza Villa Oro (1934-37) e Villa Campanella (1936) a Napoli Posillipo, e il progetto di una Villa a Positano.
[3] Il catalogo della mostra del 1964 è scaricabile dal sito del Moma, qui https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3459_300062280.pdf
[4] La questione della “continuità” è sempre stata un po’ occultata, rimossa, per ovvie ragioni di convenienza. Troppe persone sono passate da adesioni al fascismo, a volte non generiche, al nuovo corso politico. E non solo a destra o nemmeno nel centro cattolico, ma anche, spesso, nel PCI, il partito comunista più grande e influente fra quelli in paesi non comunisti. È facile parlare di opportunismo, di cambio di casacca ecc. La realtà potrebbe essere più profonda: si tratta di persone che, nel loro paese che percorreva l’avventura fascista- questo particolare nazionalsocialismo- hanno tentato di ben operare, secondo le questioni che gli si ponevano di fronte. In seguito all’esito disastroso del fascismo, hanno proseguito con impegno il loro lavoro, nell’Italia repubblicana, chi in un grande partito cattolico di centro, chi in un grande partito comunista o socialista (con un fenomeno, forse, di “socialismo di ritorno”), e solo qualcuno ha preferito condannarsi alla emarginazione in partiti fascisti di fatto anche se non di nome.
[5] “Neoliberty. The Italian Retreat from Modern Architecture” pubblicato nell’aprile 1959 su The Architectural Review
[6] Significativo, rispetto alla questione, lo scritto del 1961 di Aldo Rossi con Luciano Semerani e Silvano Tintori, “Risposta a sei domande”, in cui entra direttamente nella polemica aperta da Banham (che viene lì definito “un bravo e brillante giornalista inglese che ha una buona conoscenza dell’Italia, sia pure a livello turistico”, di cui riporto una citazione riguardo al tema: “Immaginare che oggi il problema sia quello di portare avanti i risultati della Triennale del ’36 o la polemica di Pagano, come dicono i romani, è un poco come scoprire il valore degli architetti borghesi del ‘900 torinese. Crediamo certamente nel valore della storia (che non è sempre continuità) ma siamo altrettanto convinti che lo studio della storia richieda, soprattutto nella situazione italiana di oggi, una maggiore apertura di prospettive; che sia più importante studiare Le Corbusier invece di Pagano, Loos invece di Persico, Behrens invece di D’Aronco. E cosa vuoi dire studiare la storia? Forse essere gli esecutori testamentari di questo o di quell’architetto o non poter pronunciare un giudizio critico sul movimento moderno senza essere tacciati di tradimento? No certamente. Rispetto a queste posizioni il nostro atteggiamento è chiaro; abbiamo ripetuto fino alla noia che non esiste oggi un’architettura moderna come tale, ma semplicemente esistono dei programmi e delle tendenze che, in quanto programmi e tendenze si possono discutere, approvare o disapprovare”. E stigmatizza nella frase successiva il suggerimento di Italo Insolera di un “revival razionalista”. Ora contenuto in Aldo Rossi, Scritti scelti sulla architettura e la città (1956-1972), Clup 1975,
[7] Kaufmann Emil, Von Ledoux bis Le Corbusier, Wien 1933. Pubblicata in Italia da Mazzotta nel 1973