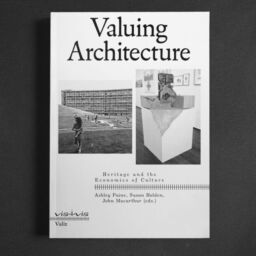Amate l’Architettura mi ha invitato a fare una riflessione sul “fatto che i decostruttivisti sono figure isolate che non hanno sviluppato un movimento organico.” Accetto volentieri perché trovo il tema poco trattato ma assai interessante, e ormai abbastanza distante per poter cominciare ad essere storicizzato. Ecco la mia opinione.

Il decostruttivismo in architettura fu una etichetta promozionale, alla stessa stregua delle definizioni di genere di musica pop. Quando, intorno al 1976-77 il punk divenne fenomeno discografico e di mass media (ossia, quasi subito), vennero sussunti in esso dai Police a Elvis Costello, dagli Stranglers a Ian Dury, da Donatella Rettore a Jo Squillo. Loro stessi compiacenti e consapevoli del fatto che questa etichetta di genere era il dispositivo con cui avrebbero potuto cavalcare la nuova onda e mettersi così in evidenza presso i mezzi di comunicazione, acquisire popolarità e pertanto affermarsi, per poter magari fare, subito dopo, ciò che davvero a loro sarebbe piaciuto fare.

Così la decostruzione in architettura. Non voglio dire che sia stato qualcosa di inconsistente, di puramente promozionale. Voglio dire che è stato anche (e forse, soprattutto) un dispositivo attraverso cui legittimare e promuovere un certo tipo di ricerca architettonica. O per meglio dire, più generi di ricerca architettonica, o, meglio ancora, più poetiche architettoniche.
Il tema “decostruzione in architettura” fu pensato soprattutto da Eisenman, intorno al 1984, e nel contesto del ribollente minestrone del post-modernismo, per poi generare la famosa triangolazione con Derrida e Tschumi. La decostruzione divenne presto l’ultimo grido, senza dubbio facilitato da una certa stanchezza nei riguardi di un approccio tendenzialmente passatista allora dominante, il tutto culminato nella famosa mostra al Moma del 1988 curata da Wigley e Johnson.
In realtà, la decostruzione in architettura, come pensata da Eisenman con l’aiuto di Derrida (entrambi, così come Gehry, una ventina d’anni più anziani di Hadid) fu una concettualizzazione, tutta elitaria, e tutta contenuta nel secolo scorso: comprese le tecniche di comunicazione/produzione (giornali e riviste di carta, mostre, radiotelevisione, disegno manuale; e le assonometrie dal basso).
Ritengo che le rapide trasformazioni tecniche, scientifiche, concettuali, dei mass media ma anche geopolitiche negli ultimi 30 anni abbiano reso obsolete sia le concettualizzazioni del decostruzionismo (ancora molto legate ai paradigmi novecenteschi, ancora molto logocentrici , eurocentrici e storicistici, proprio a dispetto del tentativo di superamento di essi ), sia i modi di legittimazione che stavano alla base di esso (attraverso il circuito accademico e riviste, entro un ambito geografico per lo più limitato a Europa e USA; forme di legittimazione tuttora operanti ma in crisi e non più in regime di monopolio).
La nuova situazione, che non è puntualizzabile proprio per la sua complessità e transitorietà sempre più vorticosa, se da un lato ha reso compiute alcune predizioni delle teorie in auge negli anni ’80 (ad esempio l’abbandono della legittimazione basata sul “logos”, in favore di una sempre più performativa e tecnica, in sé stessa autoproducente ed auto legittimante), dall’altro proprio per questo motivo ha reso impossibile qualcosa del tipo “sviluppo di un movimento organico” (per tornare alla domanda alla base di queste note).


In sintesi, così rispondo : i decostruttivisti sono “figure isolate che non hanno sviluppato un movimento organico”, perché il mondo che hanno prefigurato (con successo) non ammette qualcosa di simile a movimenti organici, ma semplicemente soggetti che intercettano, più o meno, flussi nel loro divenire, senza preordinarli, ma semplicemente dando loro un ordine sufficiente per renderli minimamente stabili entro questi flussi. Più soggetti possono essere parte di una stessa “onda”, allearsi, ma non costituire un “movimento organico”.
L’architettura resta, tuttavia, un’arte di rappresentazione. E’ questa fluidità dinamica che oggi l’architettura deve rappresentare, che oggi lo “spirito del tempo” richiede che sia rappresentata.
In questo senso, Zaha Hadid, proprio in virtù del suo tanto vituperato formalismo, è stata esemplare ed adeguata, grande interprete di questa necessità di rappresentazione. E forse, tale anche perché isolata, anche perché non davvero “decostruttivista”.
Credits
Le foto dello studio di Eisenman sono di ©Daniela Maruotti
In un suo scritto del 1984 “The Futility of the Objects: Decomposition and the Processes of Difference” (ed. italiana raccolta in La fine del Classico e altri scritti, Cluva, Venezia 1987 volume curato da Renato Rizzi), benché il termine messo in campo non fosse ancora “decostruzione”, ma “decomposizione”, esso era già connesso con teorizzazioni di Derrida: a dimostrazione, in nota Eiseman scrisse (uso la traduzione del volume italiano citato) “(la parola decomposizione) .. . è usata nel senso dialettico non metafisico che Derrida usa nella sua idea di “differenza” . Nel di poco successivo scritto “The End of the Classical”, sempre in nota, Eisenman mostra le sue riflessioni sul testo di Culler On Decostruction del 1982 direttamente collegato con le teorizzazioni di Derrida. Nel 1985 Bernard Tschumi, invitò Derrida a collaborare con loro alla progettazione di giardini tematici alla Villette, progetto che non verrà realizzato ma che darà luogo alla pubblicazione del volume Chora(l) Works.